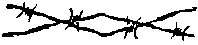 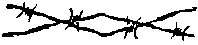 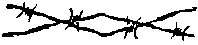
Ngor, un anno in Sudan a fare lo schiavodi Claudio MoniciGarang, il figlio di due anni aveva fame, Nyamut la giovane moglie aveva fame. Lui, padre e marito, aveva un toro bianco e un Dinka del Sudan; non mangerà mai carne della sua mandria. Sventura e maledizione colpiranno la famiglia se la fame spingerà a sgozzare l’animale che rappresenta ricchezza. L'uomo Dinka andrà al mercato per vendere il toro ad un altro uomo e coi soldi acquisterà un bue che sarà la carne per la famiglia, oppure comprerà una scorta di cereali. Era l’estate del 1988 e la carestia stringeva il cappio attorno al villaggio di Kuajak (distretto del Gogrial, Sudan centro occidentale) e Ngor Atak Luil aveva venduto il toro bianco al mercato di Abyei, 250 chilometri da casa. «Sulla strada del ritorno, a 15 miglia da Abyei eravamo una trentina di giovani Dinka con le scorte per il villaggio. I Baggara ci hanno circondati con i mitra. Erano tre volte più di noi, le nostre armi erano i sacchi di iuta. Ci hanno rubato tutto e ci hanno legati l’uno all'altro. Ero uno schiavo che per 16 giorni ha camminato nella savana, prima di raggiungere il posto dove sarei rimasto per più di un anno. Mi ricordo che ci battevano, se la stanchezza ci faceva rallentare il passo». Per Ngor Atak Luil inizia l’oblio; dall'alba al tramonto nell'azienda agricola di un padrone arabo. La notte legato mani e piedi, di giorno controllato a vista da persone armate. Per un anno non ha mai masticato carne. Solo polenta di sorgo. Un uomo Dinka è un uomo orgoglioso della sua libertà: la fierezza di un popolo. La prigionia, la schiavitù lo uccide come un parassita che si insinua lento e inesorabile nelle cellule di un corpo malato. Un nero ridotto pelle e ossa, senza più la forza nelle braccia e nella schiena che si piega sui campi, non serve più. Non vale più un pound sudanese. La libertà gli è stata "offerta", come la si infligge ad un vecchio animale da soma di cui non si ha più bisogno. Cosi accade per gli uomini neri Dinka, Naer, Silluk, Toposca, Hotuko, Acholi; carne per il barbaro commercio. Catturati nei villaggi e nella savana, schiavizzati e sfruttati; bastonati se non ubbidiscono ai comandi e abbandonati quando non servono più. Il sud del Sudan è un pozzo dove poter attingere braccia e gambe per i lavori che nessun arabo mai farà. Ngor Atak Luil non conosce la sua età. La sua famiglia non gli ha parlato del giorno che è nato nella capanna che gli ha dato l’alito di vita nella savana sudanese: un giorno come un altro, con il sole africano che lascia il posto alla luna e una nuova bocca da sfamare. Forse ha 25 anni, oppure qualcuno di più. Ma incertezza e approssimazione sono legittime se i nostri occhi scrutano il corpo di Ngor. Un uomo Dinka è altissimo, d'un nero ebano, con gli occhi sanguigni. E con i segni primitivi della scarnificazione sulla fronte, la fierezza di appartenere ad un gruppo etnico. Alto e robusto, forte e orgoglioso. Ma Ngor Atak Luil ha perso tutto questo, la sua schiena è curva e leggera: è un uomo di 45 chili, dalle dita scarnificate. Un anno di schiavitù accompagnato da cinque anni di fuga dal Sudan, attraverso il nord. E poi l'Etiopia. Da un mese il Kenya. Il suo padrone si faceva chiamare Malwal Achut, nome Dinka. Nome falso, suggerito dalla furbizia araba. Il villaggio della schiavitù era quello di Tuoun Kordofan. I suoi amici Dinka ai quali di notte era legato si chiamavano Akok Macham, Nyong Deng e Deng Aguer. Lui, lo schiavista Malwal Achut li insultava, li minacciava: «I vostri ribelli del sud non verranno a liberarvi. Noi arabi vi uccideremo tutti. Prenderemo le vostre donne e la vostra terra. Le vostre mandrie. Bruceremo le vostre case». «La notte pensavamo al giorno dopo. Alla fuga - racconta Ngor, mentre divora un pacco di biscotti e beve due tazze di the al latte -. Di notte con i miei compagni pensavamo a come scappare. Ma il sole faceva svanire i sogni, fuggire, dove? Saremmo stati uccisi. Non avevamo potere. La schiavitù era la nostra vita e la nostra speranza di tornare, un giorno, forse a casa. Il padre e la madre raccontavano a Ngor storie di uomini vestiti di bianco e con il imma, il turbante sul capo, che rapivano «i neri del sud per portarli nei paesi del nord, mai, - racconta Ngor - mai ho pensato che sarebbe capitato anche a me». Ngor Atak Luil, ricordi un episodio, un gesto di umanità da parte di chi ti aveva reso schiavo? «Un giorno il figlio adulto dell'arabo che si faceva chiamare Malwal Achut, El Nur, mi ha difeso da un altro arabo del villaggio che voleva vendicarsi perché suo fratello era stato ucciso durante un rastrellamento alla ricerca di schiavi. Voleva uccidermi. Ma El Nur mi salvò perché io servivo per i campi, solo per questo». Nel 1989 l’uomo Dinka è liberato. In tasca non ha un soldo, condotto in un villaggio dal suo ex padrone incontra un altro arabo che gli propone di lavorare nei campi alla raccolta delle arachidi, con la promessa di una paga. Dopo un mese; Ngor Atak Luil chiede al nuovo padrone, che dice di chiamarsi Salamam, lo stipendio: «I soldi per uno come te non ci sono: mio fratello è stato ucciso dalla tua gente», risponde Salaman e intanto prende un'arma: «Sei qui per i soldi? Io ti pago con i proiettili di questo fucile; se vuoi vivere è meglio che te ne vai per la tua strada». Inizia l’esodo attraverso Khartoum, Gedareg, i campi profughi in Etiopia e finalmente il Kenya: «Non potevo raggiungere la mia famiglia seguendo la strada del sud perché sarei stato ucciso». Cinque anni di patimenti e di cammino gli hanno portato via quei pochi chili di carne che Ngor aveva addosso.
Ora che sei a Nairobi hai dei progetti, raggiungerai la tua famiglia?
Comprati e venduti come bestieDa dieci a cento dollari statunitensi. È il prezzo per uno schiavo. In Sudan la tratta degli schiavi ha radici che affondano nella notte dei tempi. Secondo l’Anti Slavery international (Asi) a cadere vittime del commercio umano sono ragazzi e ragazze Dinka, Fur e Nuba. Abt, parola araba: schiavo.I ceppi alle caviglie, le catene ai polsi e la frusta per domare la ribellione o per forzare le estenuanti marce al seguito delle carovane che nel secolo scorso e ancor più indietro negli anni, solcarono il deserto sudanese diretti ai mercati della tratta umana. Khartum-Port Sudan, l’arabian road che chiude il destino di molti nella penisola arabica: le chiatte che partivano, e forse partono ancora, dall'antico porto di Suakin trasportavano gli schiavi dall'altra parte del Mar Rosso. Uomini arabi che avevano sposato giovani donne africane del sud Sudan avevano il biglietto di andata e ritorno, loro, le donne, il solo biglietto di andata. Abt, parola antica, dramma che ancora si consuma in Sudan sulla pelle delle popolazioni africane del meridione. La vicenda di Ngor Atak Luil, che raccontiamo a parte, riporta alla memoria le storie della tratta degli schiavi esercitata su larga scala e con metodi spietati dal XVI al XIX secolo. Commercio disumano abolito dal Congresso di Vienna nel 1815. Khartoum rigetta la tesi che nel Sudan la schiavitù sia ancor oggi praticata. E nel caso di Ngor Atak Luil il regime sudanese potrà obiettare che il fatto risale al 1988, un anno prima del colpo di Stato di Omar el Bashir. Ma le storie di schiavitù sono molte altre, già denunciate da fonti raccolte da Avvenire. E le denunce di Amnesty international, della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, i libri scritti da professori universitari sudanesi, sono testimonianze che pesano sulla coscienza di Khartoum che si ostina a non ammettere l’evidenza: nel Sudan la schiavitù è un fatto culturale. Il regime del Sudan nega: «Dateci un solo nome di schiavo». Eccolo il nome di uno delle migliaia di sud sudanesi che hanno patito e patiscono la soggiogazione forzata nei campi, nelle stalle o nei domicili degli arabi sudanesi. Ngor Atak Luil è stato catturato sulla strada di casa dai predoni Baggara, non è stato comprato al mercato degli schiavi dove il valore di un uomo viene battuto al più offerente che si presenta ai mercati di Safaha, El Dhein, Kadogli o Awiel. Schiavitù è anche la storia del giovane James di El Obeid. Un ragazzino di dodici anni che un benestante di Khartoum, un giorno aveva preso con sé, promettendo alla famiglia di portarlo nella capitale per farlo studiare e dargli da mangiare. Una bocca in meno da sfamare per la famiglia di James, che ogni giorno deve combattere con i crampi allo stomaco. Ma la promessa del mercante arabo si trasforma in un incubo per il piccolo James, costretto agli umili lavori di casa e obbligato a frequentare la khalwa, la scuola coranica. James fugge per le strade di Khartoum. Si arrangia come può, fino a quando incontra un gruppo di cristiani che ascoltano la sua storia di "schiavetto" tutto-fare. Ora James è tornato alla sua casa di El Obeid. I cristiani gli hanno pagato i soldi per il bus. «Il sudanese, l’arabo fa il suo dovere di musulmano - ci è stato detto a Khartoum da quelle persone che hanno aiutato James -. Ai bambini del sud Sudan è imposta la scuola islamica per convertirli all’islam e quindi arabizzarli; agli adulti si impone la conversione e di cambiare il nome in cambio di quegli aiuti che la carità internazionale spedisce in Sudan. Aiuti gestiti dal governo e dalle organizzazioni islamiche». Romolo Gessi era un esploratore italiano che nel 1876 su incarico del governatore di Khartoum, l’inglese Gordon e dietro consiglio di Daniel Comboni, organizzò un esercito di soldati Nuba per dare battaglia agli schiavisti nel Bahr el Ghazal. Vinse, Romolo Gessi. I Nuba oggi patiscono la pulizia etnica sulle montagne del Kordofan, mentre il virus della tratta degli schiavi è rimasto nel sangue di alcuni gruppi e nomadi arabi del Sudan: Baggara, un tempo allevatori di bestiame; Zaghawa, irriducibili predoni che disprezzano il lavoro nei campi: «Il lavoro è per gli schiavi; Kabadish, ambiziosi amanti delle armi e padroni del deserto: la paura per le gente dalla pelle nera, per il popolo del Bilad as Sudan, il Paese dei Negri, le terre a sud del Sahara. Chi è riuscito a fuggire dalla schiavitù parla di torture e patimenti, ma anche di mutilazioni senza ragione. Claudio Monici
|
Homepage
Sostieni la telematica per la pace, versa un contributo sul c.c.p. 13403746
intestato ad Associazione PeaceLink, via Galuppi 15, 74010 Statte (TA)
PeaceLink 1997